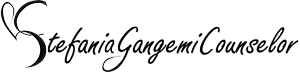Si era appena concluso un incontro dedicato all’ascolto.
Come counselor l‘ascolto attivo era una tecnica, ma soprattutto una pratica, che avevo imparato a mettere in atto sempre meglio negli anni. Durante i primi tempi del corso di counseling avevo imparato la grossissima differenza che caratterizzava l’ascolto attivo, che riguarda soprattutto i messaggi inviati dal corpo; cioè la comunicazione non verbale.
Già da giovane spesso ricevevo complimenti relativi all’essere una buona ascoltatrice. Uno dei più bei complimenti al riguardo lo avevo ricevuto da C., ricordavo ancora con precisione il luogo in cui ci trovavamo, la sala mensa di un convento, e come sedute una accanto all’altra all’estremità di un tavolo, con le sedie disposte proprio come avrei imparato anni dopo a predisporre per il setting degli incontri di counseling, avessimo vissuto quel momento come importante e forse fondante della nostra amicizia.
Lavoravamo in quel convento per riordinare l’archivio e la biblioteca della congregazione; un luogo bellissimo con un parco e una terrazza con affaccio da uno dei bei colli romani. Quando le giornate erano particolarmente fredde o ventose ci rifugiavamo dopo pranzo in quella sala mensa deserta, i commensali finivano di desinare presto, a prendere il caffè. Era accaduto varie volte che perse nei nostri dialoghi smarrissimo completamente la dimensione del tempo, tanto che di ritorno a lavoro ci rimettevamo di buona lena a recuperare il tempo “perduto”. Non avevo mai considerato quel tempo come tempo perso, era proprio in quello scorrere di pause pranzo che io e C. avevamo costruito in pochi mesi un’amicizia, un affetto e una comprensione che durano ancora dopo quasi quindici anni. Un’amicizia che non ha quasi mai sofferto della distanza che ci separa, poiché viviamo in due regioni diverse, e neanche delle differenti vite che viviamo.
In quel pomeriggio di primo inverno, con la luce che inondava l’enorme sala ricordo C. quasi incorniciata tra due finestre, una alle spalle e una alla sua destra; la luce che entrava da quelle grandi finestre ci permetteva di osservarci, i nostri sguardi riuscivano quasi a penetrare l’animo l’una dell’altra forse in una dimensione di vite passate che ci permettevano di apprezzarci e riconoscerci. C. mi stava raccontando qualcosa del suo passato e per me quel racconto era importante e interessante, mi affascinava e mi piaceva. A un tratto lei aveva guardato l’orologio e ci eravamo accorte che quella pausa caffè era durata un’ora e forse più, allora lei mi aveva detto: <<sai proprio ascoltare, quando ti parlo è come se il tuo interesse trasparisse da tutto il corpo>>.
Oggi, a un buon osservatore o a chi si occupi di linguaggio non verbale il mio saper ascoltare probabilmente traspare anche dal mio corpo, ma al tempo risposi banalmente: <<forse è per questo che ho le orecchie grandi>>! Le mie orecchie sono leggermente sproporzionate, io le definisco orecchie da uomo, non sono a sventola, ma sicuramente non sono una delle mie parti del corpo che apprezzo particolarmente.
Forse, in quel pomeriggio e durante tutte le altre volte che nel corso dei mesi ci eravamo soffermate ad ascoltarci, la cosa che avevamo imparato era che quell’ascolto nasceva dalla sincera curiosità e dall’attenzione. E si nutriva della comprensione e della possibilità di accogliere quelle che Valéry definisce “le nostre reciproche differenze”.
Per questo dopo anni di esercizio di ascolto attivo comprendo sempre più profondamente che ascoltare significa sostanzialmente accogliere l’altro: cogliere a se, abbracciare. Un abbraccio che trasmette affetto e dove non c’è spazio per il giudizio.
Solo in assenza di giudizio si apre l’opportunità di cogliere il senso dell’altro.