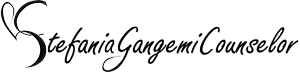Sembrava come se la mia vita si stesse spezzando in due, quel senso di immobilismo e di rassegnazione mischiata a ansia e paura che mi aveva assalito all’inizio dell’emergenza si era trasformata. Era arrivato il silenzio e mentre cercavo di capire come stavo, come stavamo tutti, le risposte sembravano banali e semplici.
La narrazione interiorizzata di ciò che accadeva dava un senso di spaesamento che poteva essere ribaltato solo modificando la prospettiva.
Per soddisfare il bisogno individuale di dare un nome all’angoscia attuiamo una strategia di emergenza che può consistere nella colpevolizzazione dell’altro. La caccia all’untore è una tecnica potente che ci permette di combattere il nemico invisibile; ma voler trovare a ogni costo un colpevole, ci fa vivere da irresponsabili. Si tratta di un atteggiamento spregevole che scaturisce dal voler dirottare la rabbia trattenuta, che in quel caso le misure di contenimento alimentavano. Una sorta di energia adrenalinica che poteva essere scaricata all’esterno, ma che creava un modello poco aderente alla realtà.
Invece adesso toccava prendersi la responsabilità, ora più che mai sentivo l’urgenza di negoziare con gli altri, ma principalmente con me stessa, trovare una soluzione che poteva essere appagante per tutti. Ribaltare la prospettiva diventava una soluzione possibile. Se è vero che la vita di ciascuno non può essere decontestualizzata dalla propria storia, allora bisognava iniziare a pensare a quella storia in maniera differente. L’idea che mi sembrava più proficua riguardava pensare alla storia come qualcosa che è stato, ma che non deve necessariamente ripetersi; si ripete se il trauma rimane attivo, perché non è stato elaborato.
Allora urgeva elaborare il trauma, osservarlo mentre accadeva, sentire cosa causava nel mio corpo, nella mia essenza.
Diventava inutile arrovellarsi a cercare di capire una situazione così complessa, l’unica cosa che potevo fare era rimanere aderente a quello che c’era. L’unica via possibile era stare in contatto con le emozioni, le sensazioni, anche quando il disagio si faceva potente e la possibilità di sfuggire era a portata di mano.
Non volevo più sfuggire al disagio: provavo a stare in quel disagio, dove la noia, l’apatia, il malessere, il sonno, l’incapacità di concentrazione o di trovare qualcosa di stimolante sembrava impossibile, non avevo altro da fare.
Il responso era: diventare abile.
Forse stavo solo farneticando, ma fortunatamente il vuoto fallato che sembrava invadermi in alcuni istanti, si trasformava quasi subito in un senso di quiete, di serenità, di riappacificazione quasi sconvolgente. E proprio per questo, forse, la possibilità di attacco o fuga era neutralizzata, non attaccavo, non fuggivo, rimanevo: per poter divenire.